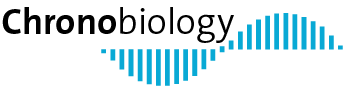Le persone che dormono male hanno più probabilità di altre di avere un cervello che sembra più vecchio di quanto non sia in realtà. Questo è il risultato di un ampio studio condotto dal Karolinska Institute. L’aumento dell’attività infiammatoria nell’organismo potrebbe spiegare in parte questa correlazione.
La carenza di sonno è associata alla demenza, ma non è chiaro se le abitudini di sonno malsane contribuiscano allo sviluppo della demenza o siano piuttosto sintomi precoci della malattia. In un nuovo studio, i ricercatori del Karolinska Institute hanno analizzato la relazione tra le caratteristiche del sonno e l’età apparente del cervello rispetto all’età cronologica. Lo studio ha incluso 27.500 persone di mezza età e anziane della UK Biobank che sono state sottoposte a risonanza magnetica (MRI) del cervello. Utilizzando l’apprendimento automatico, i ricercatori hanno stimato l’età biologica del cervello sulla base di oltre un migliaio di fenotipi cerebrali sottoposti a risonanza magnetica.
Come il sonno e il cervello sono collegati
Il cervello svolge un ruolo centrale nel sonno e lo influenza a diversi livelli. Il nucleo soprachiasmatico, che funge da orologio interno, si trova nell’ipotalamo. Registra la luce attraverso gli occhi e in questo modo controlla i nostri ritmi di veglia e sonno, anche regolando ormoni come la melatonina, che favorisce la stanchezza. Allo stesso tempo, durante la veglia si accumula nel cervello la molecola adenosina, che crea la cosiddetta pressione del sonno: più adenosina c’è, più forte è il bisogno di dormire. Il sistema di attivazione reticolare nel tronco cerebrale ci tiene svegli, mentre il nucleo VLPO nell’ipotalamo induce il sonno. Diversi neurotrasmettitori svolgono un ruolo in questo senso: Il GABA favorisce il rilassamento e il sonno, la serotonina sostiene il ritmo sonno-veglia e l’orexina ci tiene svegli – un malfunzionamento può portare alla narcolessia.
 Il sonno ha anche un forte effetto sul cervello. Durante il sonno il cervello elabora le informazioni, favorendo l’apprendimento e la memoria: Le idee creative e le esperienze emotive vengono integrate durante il sonno REM, mentre i fatti, il vocabolario o le abilità motorie vengono consolidati durante il sonno profondo. Il sonno profondo attiva anche il sistema glinfatico, che trasporta fuori dal cervello prodotti di scarto come la beta-amiloide, contribuendo a proteggere dalle malattie neurodegenerative. Il sonno aiuta anche a regolare le emozioni, a ridurre l’ansia e a migliorare il controllo degli impulsi, “resettando” allo stesso tempo le sinapsi e rafforzando le connessioni tra le cellule nervose. Un sonno adeguato e riposante porta quindi a una migliore concentrazione, a tempi di reazione più rapidi e a un aumento delle prestazioni.
Il sonno ha anche un forte effetto sul cervello. Durante il sonno il cervello elabora le informazioni, favorendo l’apprendimento e la memoria: Le idee creative e le esperienze emotive vengono integrate durante il sonno REM, mentre i fatti, il vocabolario o le abilità motorie vengono consolidati durante il sonno profondo. Il sonno profondo attiva anche il sistema glinfatico, che trasporta fuori dal cervello prodotti di scarto come la beta-amiloide, contribuendo a proteggere dalle malattie neurodegenerative. Il sonno aiuta anche a regolare le emozioni, a ridurre l’ansia e a migliorare il controllo degli impulsi, “resettando” allo stesso tempo le sinapsi e rafforzando le connessioni tra le cellule nervose. Un sonno adeguato e riposante porta quindi a una migliore concentrazione, a tempi di reazione più rapidi e a un aumento delle prestazioni.
Un sonno insufficiente può influenzare il cervello in molti modi diversi e talvolta profondi. Se dormiamo regolarmente in modo insufficiente o di scarsa qualità, il delicato equilibrio delle funzioni cerebrali viene scombussolato. In primo luogo, ne risentono la memoria e la capacità di apprendimento. Durante il sonno, le informazioni vengono elaborate e immagazzinate nella memoria a lungo termine: Fatti e abilità motorie nel sonno profondo, esperienze emotive e idee creative nel sonno REM. Se questo sonno manca, è più difficile trattenere le nuove informazioni e richiamare i ricordi esistenti.
Anche la regolazione emotiva è disturbata. La privazione cronica del sonno aumenta l’irritabilità, l’ansia e i sintomi depressivi perché il cervello è meno capace di elaborare le emozioni e di smorzare le reazioni allo stress. Inoltre, le prestazioni cognitive ne risentono: diminuiscono la concentrazione, l’attenzione, la capacità di risolvere i problemi e i tempi di reazione. Il cervello lavora in modo meno efficiente e le decisioni sono più impulsive o soggette a errori. Un altro aspetto importante è la “pulizia” del cervello attraverso il sistema glinfatico. Durante il sonno profondo, vengono eliminati prodotti di scarto come le proteine beta-amiloide e tau. Queste sostanze si accumulano se dormiamo male per lunghi periodi e possono aumentare il rischio di malattie neurodegenerative come l’Alzheimer. La carenza di sonno influisce anche sulle strutture cerebrali stesse: Gli studi dimostrano che la privazione cronica del sonno è associata a cambiamenti in aree come l’ippocampo (per la memoria) e la corteccia prefrontale (per il processo decisionale e il controllo degli impulsi).
Infiammazione lieve
La qualità del sonno dei partecipanti allo studio è stata valutata sulla base di cinque fattori auto-riferiti: cronotipo (persona mattutina o serale), durata del sonno, insonnia, russamento e sonnolenza diurna. Sono stati poi suddivisi in tre gruppi: sonno sano (≥4 punti), moderato (2-3 punti) o scarso (≤1 punto). “La differenza tra l’età cerebrale e l’età cronologica aumentava di circa sei mesi per ogni diminuzione di un punto nel punteggio del sonno sano”, spiega Abigail Dove, ricercatrice presso il Dipartimento di Neurobiologia, Scienze Infermieristiche e Società del Karolinska Institute, che ha guidato lo studio. “Le persone che dormivano poco avevano un cervello più vecchio in media di un anno rispetto alla loro età effettiva”.

Altri possibili meccanismi che potrebbero spiegare il legame sono gli effetti negativi sul sistema di smaltimento dei rifiuti del cervello, che è attivo principalmente durante il sonno, oppure il fatto che un sonno insufficiente influisce sulla salute cardiovascolare, che a sua volta può avere un impatto negativo sul cervello. I partecipanti alla UK Biobank sono più sani della popolazione generale del Regno Unito, il che potrebbe limitare la generalizzabilità dei risultati. Un’altra limitazione dello studio è che i risultati si basano su dati di sonno auto-riferiti. Lo studio è stato condotto in collaborazione con ricercatori della Swedish School of Sport and Health Sciences, della Tianjin Medical University e della Sichuan University in Cina.
Fattori di rischio per l’invecchiamento precoce del cervello
Stimando l’età cerebrale delle persone a partire dalle scansioni di risonanza magnetica mediante l’apprendimento automatico, un team guidato da ricercatori dell’UCL ha identificato diversi fattori di rischio per l’invecchiamento cerebrale precoce. Hanno scoperto che una peggiore salute cardiovascolare all’età di 36 anni prediceva un’età cerebrale più avanzata, mentre gli uomini tendevano ad avere un cervello più vecchio rispetto alle donne della stessa età, si legge su The Lancet Healthy Longevity.
L’età cerebrale più avanzata era associata a punteggi leggermente peggiori nei test cognitivi e prevedeva anche una maggiore contrazione cerebrale (atrofia) nei due anni successivi, suggerendo che potrebbe essere un importante marcatore clinico per le persone a rischio di declino cognitivo o di altre malattie cerebrali. L’autore principale, il professor Jonathan Schott (UCL Dementia Research Centre, UCL Queen Square Institute of Neurology), ha dichiarato: “Abbiamo scoperto che, nonostante l’età reale molto simile di tutte le persone coinvolte in questo studio, c’erano differenze molto grandi nell’età stimata dal modello computerizzato per i loro cervelli. Speriamo che questa tecnica possa un giorno essere uno strumento utile per identificare le persone a rischio di invecchiamento accelerato, in modo da poter offrire loro strategie di prevenzione mirate e precoci per migliorare la loro salute cerebrale”. I ricercatori hanno applicato un modello di apprendimento automatico basato sulla risonanza magnetica per stimare l’età cerebrale dei partecipanti allo studio Insight-46, finanziato dall’Alzheimer’s Research UK e guidato dal professor Schott. I partecipanti allo studio Insight-46 sono stati estratti dalla coorte di nascita britannica del 1946 del Medical Research Council’s National Survey of Health and Development (NSHD). Poiché i partecipanti hanno preso parte allo studio per tutta la vita, i ricercatori hanno potuto confrontare la loro attuale età cerebrale con vari fattori relativi all’intero corso della loro vita. I partecipanti avevano tutti tra i 69 e i 72 anni, ma la loro età cerebrale stimata variava da 46 a 93 anni.

I ricercatori hanno anche scoperto che l’età cerebrale avanzata era associata a livelli più elevati di proteina neurofilamento leggero (NfL) nel sangue. Si ritiene che livelli elevati di NfL derivino da danni ai nervi e sono sempre più riconosciuti come un utile marcatore di neurodegenerazione. La dottoressa Sara Imarisio, responsabile della ricerca di Alzheimer’s Research UK, ha dichiarato: “Lo studio Insight 46 sta aiutando a saperne di più sulle complesse relazioni tra i diversi fattori che influenzano la salute del cervello delle persone nel corso della loro vita. Utilizzando l’apprendimento automatico, i ricercatori di questo studio hanno trovato ulteriori prove che una peggiore salute del cuore nella mezza età è associata a un maggiore restringimento del cervello in età avanzata”.
Altri fattori negativi
L’invecchiamento precoce del cervello può essere favorito anche da altri fattori di rischio, che di solito si rafforzano a vicenda, ad esempio l’alimentazione gioca un ruolo decisivo: un elevato consumo di zuccheri e grassi, la mancanza di acidi grassi omega-3, di vitamine o di antiossidanti possono favorire l’infiammazione del cervello e ridurre la neuroplasticità. Anche la mancanza di esercizio fisico è dannosa, poiché l’attività fisica migliora l’afflusso di sangue al cervello, stimola la crescita di nuove cellule nervose e rafforza le funzioni cognitive.
Lo stress cronico e la tensione mentale prolungata portano a una sovrapproduzione di cortisolo, che può danneggiare regioni cerebrali particolarmente sensibili come l’ippocampo e la corteccia prefrontale, compromettendo la memoria, la capacità di apprendimento e la regolazione emotiva. Inoltre, il fumo, l’eccessivo consumo di alcol e altre droghe aumentano la tossicità neuronale e favoriscono l’infiammazione, aumentando il rischio di declino cognitivo e di malattie neurodegenerative, mentre anche i fattori sociali e l’insufficienza mentale giocano un ruolo: chi ha pochi contatti sociali o è poco stimolato mentalmente offre al cervello meno stimoli, il che può ridurre le prestazioni cognitive. Infine, fattori ambientali come l’inquinamento atmosferico o l’esposizione cronica a metalli pesanti e sostanze chimiche tossiche contribuiscono all’infiammazione e al danneggiamento del cervello.